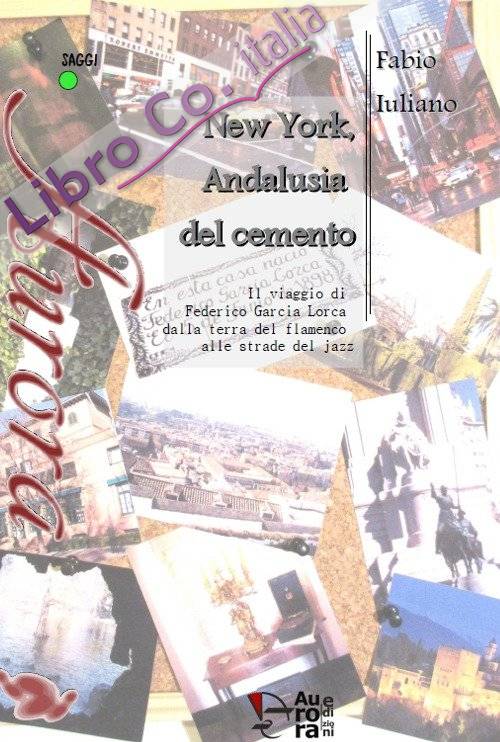“L’aurora che geme a New York”, note sul Lorca americano
di Lorenzo Spurio – Il quotidiano spagnolo La Vanguardia ha pubblicato in data 5 maggio 2020, nella sua versione online, un articolo dedicato al poeta Federico García Lorca e alla sua esperienza americana con uno sguardo all’odierna condizione sociale gravata dalla pandemia del Covid-19, scritto dalla giornalista María Dolores Cano Menéndez.
La metropoli, antro di marginalità e contaminazione
Nell’ultimo periodo della sua permanenza in America – durante la quale frequentò un corso di lingua inglese alla Columbia University, conobbe Antonieta Rivas Mercado e Nella Larsen – viaggiò a Cuba, dove era stato invitato a tenere delle conferenze. Sull’isola caraibica, a contatto con una dimensione pienamente latina, il poeta disse di sentirsi come a casa, come fosse una seconda patria. Lì senz’altro conobbe Nicolás Guillén e si avvicinò alla sua poetica musicale, pregna di quel duende che aveva esaltato nella tradizione orale flamenca.
Ne è esempio chiarificatore il componimento dal titolo “Son de negros en Cuba” dove la parola “son” non sta per la terza persona plurale del verbo essere (“sono”) ma richiama quel canto e quella danza tipiche di Cuba il cui ritmo sono dati dalla mezcla di musicalità spagnole con elementi e l’uso di strumenti primitivi, della tradizione afro-cubana (Guillén ne avrebbe raccolti numerosi in una delle sue opere principali, Motivos de son, del 1930).Lorca viaggiò alla volta dell’America nel 1929, accompagnato da Fernando de los Ríos, e rimase sul continente americano per ben nove mesi durante i quali, oltre a frequentare poeti e artisti locali, prese parte alle riproduzioni di pellicole del cinema americano, frequentò i vari quartieri della metropoli, scrivendo con acribia nelle sue poesie delle contraddizioni e del senso di sfiducia provato dinanzi alla frenesia di un’umanità annichilita e asservita al dominio consumistico.
Trascorse ore felici a Coney Island, la celebre isola dei divertimenti, forse incontrò il poeta disadattato Hart Crane (grande amante, come lui, di Walt Whitman che nella sua lunga Ode richiama come “l’uomo con le farfalle nella barba”) che, pochi anni dopo, si lasciò morire nelle acque del Golfo del Messico; entrò in stretto contatto con la comunità nera, afro-caraibica, presente nel quartiere di Harlem, con la quale si senti in profonda sintonia, come nel suo territorio, l’Andalusia, aveva fatto nei confronti dei gitani. Durante la sua permanenza visitò, nel Vermont, anche l’amico Philip Cummings, giornalista e critico, che – come riportano le testimonianze deducibili dalla corrispondenza – gli pagò in anticipo il lungo viaggio che fece in treno sino a casa sua[1], a Eden Mills, non lontana dal confine con il Canada.
Lorca va paragonando, nei suoi colloqui con la stampa, le varie città cubane che visita (L’Avana e Santiago, fra tutte, ma anche Cienfuegos) ai vari capoluoghi dell’Andalusia: sono città che gli ricordano tal vez Malaga, otras veces Cordoba o Cadice. Ian Gibson e la critica ufficiale sono concordi, anche in base all’entusiasmo col quale il poeta dimostrò di vivere quei momenti (lo ricorderà bene anche Alfredo Mario Ferreiro in una successiva lettera-testimonianza), nel sostenere che fu proprio a Cuba, in quella latinità primitiva, così speziata nella popolazione creola e verace, che Lorca visse meglio la propria condizione omosessuale o, per lo meno, iniziò quel processo interiore di maggiore accettazione, un progressivo allontanamento dalla frustrazione che nella Grande Mela e a Eden Mills aveva dominato. Ossessione amorosa che, però, come ben sappiamo, mai lo abbandonò nel corso della sua breve esistenza. Quando nel 1935 Lorca ritornò in Spagna da un secondo viaggio americano (Buenos Aires e Montevideo) che lo aveva visto acclamato come un torero (come ricorderà nella corrispondenza con l’amata madre Vicenta), ormai all’apice del suo successo (come drammaturgo, va ricordato, non tanto come poeta, dove diventerà grande, un classico, solo dopo la sua morte) le animosità e i rigurgiti di violenza di quelli che sarebbero diventati i due bandos (fazioni) del conflitto civile, erano esplosi. Lorca era additato dai reazionari e monarchici non solo come comunista (addirittura, in maniera mendace come espia rusa) ma quale maricón (omosessuale, in un’accezione fortemente dispregiativa, che potremmo rendere nella nostra lingua come “invertito”, “checca” o “finocchio”): situazione, questa, che non verrà mai meno – di contro alla sua fama indiscussa come intellettuale – e che di certo fu motivo di sofferenza interiore.
Nell’articolo che segue, da me tradotto in italiano, si ripercorre un po’ alcuni degli elementi di quella lunga permanenza sul territorio americano (del viaggio a New York e Cuba nel 1929-1930 sul quale molto ha scritto il critico Andrew A. Anderson) con particolare attenzione alla prima fase, quella newyorkese, città alla quale dedicò molti componimenti, dal taglio secco e dal verso acuminato, non di rado pervasi da un velame surreale (come in effetti l’opera Poeta en Nueva York, che sarebbe stata pubblicata solo nel 1940, venne ascritta, affine all’avanguardia surrealista), critica e angustiata da quella società americana che aveva eretto il capitalismo come sua unica legge di vita a dispetto del dominio animale (rappresentato nelle poesie in stato vegetativo, smembrato, dilaniato, morente e putrescente), della salvaguardia del pianeta (New York è caotica e inquinata), all’inseguimento di quel bitume liquido che è il denaro che distoglie gli uomini dai veri significati della vita.
Non va dimenticato che Lorca sperimentò con i propri occhi la disperazione diffusa che fece seguito, nell’ottobre del 1929, al Crollo della Borsa di Wall Street. Momento di profonda crisi per l’economia americana, che portò a un’inflazione senza pari, disoccupazione, perdita dei risparmi, indignazione, casi di suicidio e una convulsione irrefrenabile. Iniziò la Grande Depressione. Il poeta osservò il tutto meticolosamente e lo descrisse: a modo suo, è chiaro. La sua non è una cronica dei fatti ma un coinvolgimento empatico con l’ambiente della megalopoli nel quale si trova, a lui estrano, – grattacieli, ponti metallici, uomini che si ubriacano e urinano per la strada, il fiume di un colore troppo scuro – che lo porta, con uno sguardo visionario e in qualche modo premonitore, a tracciare le linee di una deriva economica, sociale e morale.
L’articolo che segue, apparso su La Vanguardia, sottolinea gli aspetti, nelle poesie di questo periodo, nei quali Lorca aveva già nel 1929, dunque più di ottant’anni fa, percepito le idiosincrasie americane, facendo risaltare le storture della società, le inesattezze, le aberrazioni, i casi di deprecabile marginalizzazione, la povertà di alcuni quartieri e il disinteresse generalizzato degli abbienti, finanche il dominio di un’aria pesante (inquinata, con gas mefitici), di tombini che ricevono acqua infetta, di uno spazio apparentemente ospitale sebbene asettico dove, invece, sembra essersi annidato il male, il virus, il germe di una contaminazione tanto sanitaria quanto sociale.
Ecco perché, nel bel mezzo di questa ansia e crisi generalizzata dove ci troviamo, a causa di questa epidemia che ha colpito il mondo intero dai primi mesi di quest’anno, l’autrice dell’articolo ha tenuto a rivendicare questi prodromi della megalopoli malata, della città più sviluppata e moderna al mondo che, complice in qualche modo l’uomo stesso che la abita, di colpo si trova sprofondata in un clima irreale, tra paranoia e delirio, invasa da un agente contaminante pericoloso, invisibile, che ha portato morti e stravolgimenti nelle vite di tutti.
Le predizioni di Lorca – La Vanguardia, 05/05/2020
di María Dolores Cano Menéndez – Il poeta proclamò il futuro trionfo del naturale, del sano, del non contaminato e lo fece a New York, una delle città più colpite ora dal Coronavirus.
Il poeta granadino Federico García Lorca viaggiò a New York nel 1929, visita che ispirò la raccolta di poesie surrealiste Poeta en Nueva York nella quale denunciò il modo di vivere della città dei grattacieli, centro del capitalismo e del progresso tecnologico.
Utilizzò in questa opera una tecnica innovatrice, avanguardista: verso libero, visioni apocalittiche, immagini allucinanti e versi lunghi, con i quali descrisse un mondo disumanizzato che schiavizzava e torturava i più deboli: bambini, animali, la natura e in particolar modo la razza nera.
In Andalusia, la sua terra, aveva scritto poesie sulla vita dei gitani emarginati (Romancero gitano). A New York lo farà sui neri, schiavizzati e sottomessi agli usi spietati della civilizzazione nordamericana e alla sua cultura della morte.
Dopo aver passeggiato per la città, il poeta si sente “assassinato dal cielo”[3], tra i grattacieli incassati come tombe che s’innalzano verso il cielo e i treni sotterranei (“forme che vanno verso la serpe”).
Nella famosa poesia “La aurora” viene descritta questa grande urbe come spazio di terrore nel quale si ammucchiano masse di lavoratori neri, resi schiavi.
Una città “[dove] non esiste un domani né speranza possibile” solamente “un uragano di negre colombe che sguazzano nelle putride acque, immense scale cercando fra le ariste nardi di angoscia disegnata, monete a sciami furiosi [che] penetrano e divorano bambini addormentati”.
Nei quartieri “gente che vacilla insonne appena uscita da un naufragio di sangue”; insonne si sveglia presto per andare al lavoro sotto “la luce sepolta da catene e rumori in [una] sfida impudica sfida di scienza senza radici”.
In “Nueva York (Oficina y denuncia)” la città è un inferno dantesco, uno spazio diviso tra due blocchi contrapposti, come due fazioni in lotta: i sostenitori del progresso e gli schiavi sottomessi a quest’ultimo.
“Io denuncio tutta la gente che ignora l’altra metà, che alza i suoi monti di cemento dove palpitano i cori degli animaletti che si dimenticano e dove tutti cadremo nell’ultima festa dei buchi”. È un anticipo di profezia: il trionfo sarà, alla fine, della natura, del sano, del non contaminato.
“Non è l’inferno, è la strada. Non è la morte, è la bottega di frutta”. Sangue di esseri liberi (animali e marinai) che fuoriesce dalle moltiplicazioni, dalle divisioni e dalle somme (scienza, finanza, Borsa). Sangue che conduce alla malattia del corpo e dello spirito. Sangue che versano i milioni di vittime ogni giorno (anatre, maiali, colombe, mucche, agnelli, galli,…).
Nella mattinata “i treni interminabili di latte, i treni interminabili di sangue e i treni di rose ammanettate dai commercianti di profumi”, di mucche schiacciate al punto da emettere terribili strilli che “riempiono di dolore la valle, dove l’Hudson si ubriaca di olio” (le acque pulite del fiume sono contaminate con l’olio sporco delle imprese, delle fabbriche).
Harlem è il quartiere degli afro-americani a New York, che il poeta vede minacciato dalla civilizzazione degli ascensori e delle automobili. “El rey de Harlem” è una poesia di denuncia, dove si parla del grande re prigioniero con un abito di portinaio che, con un cucchiaio di legno, cava gli occhi ai coccodrilli e colpisce il didietro delle scimmie, per soddisfare la sazietà, mai appagata, dei bianchi.
Esiste una minaccia, il sangue di tutti i torturati, massacrati, assassinati, sbeffeggiati (“morti infarinate e cenere di nardo”), che si presenterà per inondare tetti e terrazze da dove tutti i newyorkesi vorranno fuggire ma non riusciranno a farlo “il midollo del bosco penetrerà dalle fessure”. Non ci sarà scappatoia. “Attendete sotto l’ombra vegetale del vostro re che cicute e cardi e ortiche facciano cadere le ultime terrazze”.
In “Danza de la muerte” si racconta di come la vendetta si originerà. Gli animali morti si sono riuniti in un’arca, come quella di Noè, il mascherone che dall’Africa è arrivato a New York: “Arena, caimano e paura sopra New York!”. Giungerà a sputare veleno e a ballare tra colonne di sangue e di numeri, tra uragani d’oro e gemiti di operai fermi che latreranno, notte buia, per il tuo tempo senza luci. Il mascherone, “Che onda di fango e lucerna sopra New York!”. Oh, selvaggia America del Nord! Oh, impudico! Oh, selvaggio!
Il poeta non vuole che balli il Papa né il re, né il milionario né le statue, “né [i] costruttori, gli smeraldi, i folli o i sodomiti. […] I cobra fischieranno agli ultimi piani, le ortiche faranno tremare cortili e terrazzi, la Borsa sarà una piramide di muschio, spunteranno le liane dopo i fucili”.
Nessuno dormirà a New York (“Ciudad sin sueño”[4]) perché un giorno: “I cavalli vivranno nelle taverne e le formiche curiose andranno all’assalto dei cieli gialli che si rifugiano negli occhi delle vacche. Un altro giorno vedremo la resurrezione delle farfalle disseccate e procedendo ancora in un paesaggio di spugne grigie e barche mute vedremo brillare il nostro anello e nascere rose dalla nostra lingua”.
Il poeta avverte: “Sveglia! Sveglia! Sveglia! Quelli che ancora hanno i segni di fango e acquazzone, quel ragazzo che piange perché non sa l’invenzione del ponte o quel morto che non ha più che la testa e una scarpa, bisogna portarli al muro dove iguane e serpi attendono, dove attende la dentatura dell’orso, dove attende la mano mummificata del bambino”.
Il vigore del selvaggio, massacrato dalla civilizzazione, dalla tecnica, dal denaro, finirà per vincere. Potrà così imporsi, finalmente, la natura, asfissiata, malata, esausta, moribonda, assassinata?
Esprimo, al pari del poeta, il mio desiderio di poter vedere le nostre città piene di muschio, di terra, di fiori, di erba, di uccelli, di alberi frondosi, di aria pulita e di potermi tuffare nelle acque trasparenti dei mari, con un fondale nitido.
Dopo il confinamento [a causa del Corona Virus] ci saranno ancora aria inquinata, irrespirabile, il rumore assordante, la massificazione? È questo il “progresso” che ci aspetta per il domani?
Fonte: Alla volta di Leucade, il blog del professor Nazario Pardini